Cile, quattro mesi di rivolta: reportage da Santiago
- 3 feb 2020
- Tempo di lettura: 6 min
Aggiornamento: 7 apr 2020
di Stefania Stipitivich*

Un paese definito «esemplare» esplode di rabbia dallo scorso ottobre. Le proteste contro il neoliberismo e le disuguaglianze mettono a nudo la realtà cilena. Le piazze, gli scontri, la paura e le speranze di un popolo che vuole costruire una società più giusta. Il racconto e le foto di Stefania Stipitivich
La galleria fotografica:
Lunedì 14 ottobre 2019 il governo di Sebastián Piñera ha decretato l’aumento del costo del trasporto pubblico nell’ora di punta e da allora sono iniziate le proteste.
Un rialzo dal costo altissimo in termini di mobilità umana ma soprattutto per ciò che riguarda i diritti di più di cinque milioni di abitanti, concentrati in una metropoli stratificata e classista quale è Santiago. Oltre due milioni e mezzo di persone ogni giorno usufruiscono del trasporto pubblico e il biglietto costa l’equivalente di circa un euro a viaggio.
Questo aumento è stato la miccia che ha fatto esplodere l’indignazione latente nell’animo dei cileni e ciascuno ha trovato le proprie ragioni per scendere in piazza.
Una di queste è il lavoro, generalmente sottopagato: solo negli ultimi mesi è stato raggiunto l’accordo per abbassare l’orario lavorativo da 45 a 40 ore settimanali ed il salario minimo (ovviamente per molti lavoratori è inferiore) è di 301mila pesos - circa 380 euro -.
La vita in Cile è cara quasi quanto in Italia. Per avere la pensione si devono versare contributi gestiti da compagnie private, le quali erogano contributi pensionistici miseri. Anche per avere cure di buon livello ci si deve affidare al privato. Gli studenti e le loro famiglie si indebitano per poter studiare all’università, i costi degli affitti sono alti, fare la spesa nei supermercati è proibitivo per i più. I mezzi pubblici, negli orari di punta, esplodono di persone. Chi può permettersi un’auto rischia di restare intrappolato per ore in un traffico congestionato, per non parlare della qualità dell’aria di Santiago.
Ma torniamo alle proteste, animate principalmente dagli studenti dei licei e delle università. Le principali stazioni della metropolitana di Santiago sono circondate dai carabineros de Chile, autorità che gode di un’autonomia costituzionale lascito di una vecchia legge dei tempi della dittatura: generalmente durante le manifestazioni non brillano per umanità.
A scendere in piazza sono i figli e le figlie di una generazione nata nell’epoca della dittatura, cresciuti in una società ormai iper-capitalistica nella quale il passaggio fra il prima e il dopo Pinochet è stato poco dibattuto e condiviso. I figli e i nipoti di quei desaparecidos che continuano a non aver una voce, vittime di un silenzio storico e politico che non apre spazi al dialogo e all’elaborazione del passato (basti pensare che in Cile non esiste alcun corrispettivo della festa della Liberazione italiana).
Generazioni all’apparenza indifferenti e poco coscienti del passato hanno iniziato a mobilitarsi con forza. Come tutte le proteste massive, le sfumature sono diverse quanto a intensità e azioni.
Il flusso di persone nella direzione di plaza Italia - una delle piazze principali della città, quei luoghi in cui i tifosi si riuniscono a festeggiare la squadra del cuore o si fa il conto alla rovescia a Capodanno - è interminabile. I manifestanti si vanno sommando con i fiumi di lavoratori che dai quartieri alti tornano a casa verso i loro barrios più remoti, perché impossibilitati a prendere i mezzi pubblici bloccati dalle proteste.
A Obispo Donoso, una strada di un quartiere borghese dove all’apparenza tutto è tranquillo, si sentono le grida dei manifestanti, le esplosioni dei lacrimogeni e si vedono i fumi degli incendi appiccati in diversi punti della città.
Nei quartieri meno abbienti la protesta diventa più violenta. L’odore dei lacrimogeni sparati a plaza Italia entra nelle case, aumentano i suoni delle sirene e gli elicotteri.
Il presidente, dopo aver festeggiato in un ristorante del centro il compleanno del nipote, decreta lo stato d’emergenza: è venerdì 18 ottobre. Nelle strade risuona il rumore del cacerolazo, un sostegno alle proteste con i cucchiai battuti sulle pentole.

Sabato 19 il governo ritira il provvedimento sul trasporto pubblico. Al supermercato, affollatissimo, tutti comprano in maniera smodata. Fuori, cortei. Per le strade ci sono famiglie, anziani, tutti con i loro coperchi e cucchiai.
La sera però la situazione degenera, il governo ha decretato il toque de queda, il coprifuoco. Passano gli elicotteri con i fari spianati sulle strade.
La mattina dopo i supermercati sono chiusi per evitare i saccheggi. In un quartiere povero tre persone che stavano saccheggiando un supermercato sono morte, forse uccise dai poliziotti. Continuano i botti, mentre i manifestanti scappano dai lacrimogeni. Arriva una camionetta della polizia ed escono i militari antisommossa.
Ad avenida Providencia, una delle arterie principali della città dove normalmente il traffico è congestionato e l’aria irrespirabile, non ci sono macchine, solo ragazzi. Le fermate degli autobus sono a pezzi, i palazzi imbrattati. Alle sette di sera riparte il coprifuoco ma la gente continua a stare in strada. Ogni tanto riprende il cacerolazo. Ogni tanto suoni di sirene, fumo, odore di lacrimogeni.

Passano le settimane ma la situazione continua a essere incerta e imprevedibile.
Come riassume laconicamente uno degli slogan della protesta, "no tenemos nada que perder": le persone continuano a scendere in piazza e per la principale arteria della città si vedono scene di guerriglia urbana. I manifestanti chiedono delle risposte concrete a un presidente che, nonostante la pressante richiesta di dimettersi, rimane avvinghiato alla sua poltrona.
Nessuna soluzione sembrerebbe realmente sufficiente a placare la rabbia. Tra le principali istanze c’è la riforma della Costituzione, un lascito della dittatura che i manifestanti criticano aspramente. Sono iniziate le consultazioni per cambiarla (si terrà un referendum popolare ad aprile) ma i frutti si vedrebbero fra un paio d’anni e per chi non ha nulla da perdere ciò non può bastare.
I numeri sono allarmanti, e altrettanto allarmante è la difficoltà nel riuscire a reperirli: a parte i report delle organizzazioni indipendenti, ci si deve affidare ai social, dove impazzano notizie di ogni tipo, specialmente quelli stranieri, dai quali si ottengono più informazioni che dai media cileni.
Oggi, a quasi quattro mesi dall’inizio delle proteste, i morti sono almeno 30, i feriti quasi 4mila, molti dei quali colpiti agli occhi dai proiettili di gomma sparati dai poliziotti. Migliaia gli arrestati, centinaia le denunce per stupro o tortura.
Poi c’è la ferita inferta al tessuto urbano, ai beni culturali, agli edifici. In centro i semafori sono rotti, i lampioni delle strade fuori uso. La notte barricate in fiamme bloccano le strade, le case e i palazzi sono coperti di stencil, cartelli, striscioni e graffiti.
Passeggiare per le vie centrali della città porta alla memoria due muri: quello fra Palestina ed Israele ed il muro di Berlino. Le strade di Santiago sono come un gigantesco muro dove dare sfogo al malcontento, a volte con parole furiose, altre con disegni e opere artistiche, la somma dei quali danno un aspetto completamente diverso a Santiago, decadente, underground, irriconoscibile.
Molti negozi e attività commerciali non aprono per paura dei saccheggi, tanti lavoratori faticano ad arrivare al lavoro a causa del danneggiamento di alcune linee della metropolitana: il paese rischia una recessione economica della quale ci si renderà conto solo nei prossimi mesi, ma che già oggi aleggia negli animi delle persone.
Infine c’è la paura, di cui non si parla molto, forse proprio per scongiurare i cattivi presagi: molti temono la degenerazione delle violenze, se non addirittura un (altro) colpo di stato.

Tirando le somme, quali sono gli aspetti positivi di questo periodo di sconvolgimenti profondi del tessuto sociale e politico cileno? Il fatto che il popolo si sia unito e in modo compatto si sia alzato per far valere i propri diritti; il fatto che nonostante la brutalità della repressione le persone non si siano fatte intimorire e continuino a farsi sentire; il fatto che si sia riusciti a mettere in discussione un sistema che sembrava immutabile e soprattutto che si stia creando una grande unità in senso orizzontale.
In gran parte dei quartieri della capitale si stanno organizzando dei cabildos, riunioni aperte e partecipate dove ci si incontra per discutere collettivamente il da farsi, nella speranza di costruire una società più giusta.
Il Cile affronta un passaggio di proporzioni storiche, nel quale è in gioco il futuro della sua democrazia. La speranza è che la mobilitazione, le morti e le speranze degli ultimi mesi non siano stati vani.
* Stefania Stipitivich è un'antropologa e assistente sociale esperta di fenomeni migratori. Appassionata di viaggi, è tra i fondatori di Osmos, collettivo multidisciplinare che racconta realtà al margine.

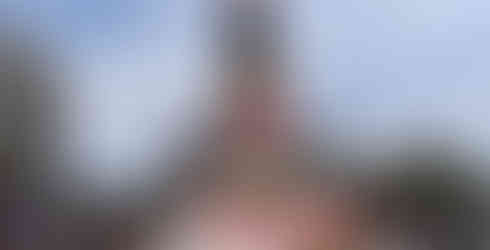


















































É impressionante il silenzio del mondo, il non parlare, quasi a volere dimenticare il popolo cileno che poco é riuscito as ottenere da quegli storici anni '90 che avrebbero dovuto rappresentare una svolta davvero importante. La povertà, lo sfruttamento, l'impossibilità a muoversi liberamente...non sembrano interessare nessuno. Dove finisce l'unità dei popoli? Forza popolo cileno, nn abbassate la voce, siate forti x tutti quei bimbi di oggi, uomini di domani.